 | |
Francesco Spè
Il Web e l’arte della manutenzione della notizia di Alessandro Gazoia (aka Jumpinshark) è un libro
importante. Per quanto ne so è il primo che analizza
sistematicamente e specificamente il giornalismo digitale in Italia.
Dal libro emerge un quadro in cui grandi testate che sono andate
online (Repubblica e il Corriere della Sera su tutte) e più o meno
piccole testate native digitali competono per accaparrarsi i click
degli utenti e accrescere la loro unica fonte di introito che è la
pubblicità. In questo contesto le notizie scandalistiche e curiose
della colonna di destra, che sono un po’ il marchio distintivo e
onnipresente del siti di informazione online, sono solo una parte di
un fenomeno ampio in cui l’intreccio di fattori come la crisi
economica e la scarsa propensione degli utenti a pagare per i
contenuti online creano un clima poco favorevole alla sperimentazione
di approcci innovativi che accrescano indipendenza ed autorevolezza
del giornalismo digitale. In
questa intervista fiume, a cui Jumpinshark si è pazientemente
sottoposto, partiamo dalle suggestioni del libro per allargare il
discorso all’editoria digitale e alle opportunità, e limiti, di
Internet come mezzo di informazione: Jumpinshark ci racconta come si
fa la “manutenzione della notizia” sul web e di come il contesto
digitale (ed economico) molto spesso imponga vizi e virtù del modo
di fare comunicazione online come oggi lo conosciamo.
DF: Sul web sei noto come Jumpinshark e prima che uscisse il libro non ti eri mai firmato con nome e cognome. Come mai questa volta hai scelto di firmarti anche Alessandro Gazoia?
Sono convinto che pubblicando solo con il mio pseudonimo, nickname, nom de plume avrei danneggiato il libro e la casa editrice. Se avessi scritto un testo narrativo lo avrei firmato come Jumpinshark, affrontando volentieri le critiche, serie e meno serie, di molti (Jumpinshark è pseudonimo stupido, d’accordo, ma, si licet, Italo Svevo non è nome vero e Peter Finlay con il nom de plume DBC Pierre, dove DBC sta per dirty but clean, ha vinto un Booker Prize…). E se avessi scritto un saggio sulla street art in Italia o un fumetto (Zerocalcare, Makkok ecc.) avrei “dovuto” usare uno pseudonimo, perché in quei contesti e in quel genere letterario va bene cosi. Il nostro comune amico Flavio Pintarelli pubblicherà un libro sullo skate per Agenzia X e gli continuo a dire, scherzando sul serio, di trovarsi al più presto un nick d’impatto (forse Pintask8 spacca abbastanza), perché in quel caso, stimato editore di movimento e tema metropolitano, il mero nome anagrafico stona, diciamo. Invece scrivere un testo sul giornalismo italiano e firmarlo con uno pseudonimo crea problemi, perché, in quel contesto italiano (e non solo italiano), si tende a considerare le identità di rete come qualcosa di poco serio e molto deresponsabilizzante. E se anche il libro fosse stato preso in considerazione mi avrebbero messo nella posizione del blogher cupo che trafika con le parole e scrive il libro contro i giornalisti... Non volevo quindi dover continuamente difendere lo pseudonimo e (argh) la qualifica di blogher, spostando su questi l’attenzione; non sarebbe stato giusto né per il testo né per l’editore: il mio ebook si sforza di essere oggettivo ed è (per quel che ne comprendo io) onesto, il taglio non è polemico e le critiche, pur presenti, evitano sempre l’aggressione e le urla. Quindi, come diceva mia nonna, paese che vai usanza che trovi e via con Alessandro Gazoia se serve a discutere nel merito.
DF: Veniamo al libro. Innanzitutto il prezzo, estremamente basso, €1,99, e il titolo.
Per Minimum Fax
l’uscita solo in
ebook era un esperimento e in generale nel mercato degli ebook c’è
una forte politica di aggressione sul prezzo (ad esempio Einaudi
vende a €6.99 Ulisse: Nella traduzione di Gianni Celati). Il
titolo è stato scelto da Marina Testa di Minimum Fax. Io ero
riuscito a tirar fuori solo qualcosa di essenziale, e meno attraente,
come “Il giornalismo digitale in Italia”.
DF: Il libro è ricco di dati e
“casi di studio”. È quasi una mappa per conoscere lo stato del
giornalismo digitale in Italia, anche in confronto con esperienze
estere che sembrano essere più coraggiose e innovative. Come è
stato accolto dai giornalisti il tuo testo, scritto da un “laico”?
Ero fiducioso che un testo dal costo
non alto sul giornalismo digitale in Italia potesse essere bene
accolto, perché vedevo che il tema era molto discusso e c’era lo
spazio per un lavoro che provasse ad essere una panoramica. Speravo
quindi che potesse avere una discreta circolazione, soprattutto tra
gli addetti ai lavori. Mi sembra che il libro sia stato accolto bene.
Ci sono state varie recensioni (dal Manifesto al Venerdì di
Repubblica, in un quadratino ma conta tutto) e interviste (da Tiscali
a Vice) e un lungo estratto è finito su Il Post. Inoltre, con grande piacere e stupore, ho ricevuto un invito di
presentazione del libro dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Non credo che i giornalisti italiani
pensino che viviamo nel paese con la migliore stampa del mondo. E il
fatto che io non sia iscritto all’Ordine dei Giornalisti non
impedisce loro di valutare il testo con obiettività. Lo scopo del
libro non è poi criticare la singola testata e tanto meno la singola
notizia. Piuttosto faccio vedere come un certo modo di fare
informazione, molto basato su una componente di “colonna di
destra”, oggi non sia nemmeno economicamente vincente. Nel testo ci
sono poi anche delle parti di critica culturale e analisi
dell’informazione. Non penso di dire delle cose inedite, ma provo
ad includerle in un ragionamento comprensivo forse utile anche a chi
lavora nel campo.
width="350"> lang="it">
Titolo del Corriere giusto una punta inappropriato e falso cfr buzzfeed.com/katieheaney/fa… twitter.com/jumpinshark/st…
— jumpinshark (@jumpinshark) 27 marzo 2013
DF: La sensazione di utente di
siti di informazione è che, a parte alcune eccezioni, i giornalisti,
ma anche gli editori, non appaiono del tutto a proprio agio nel fare
informazione sul web. In particolare in Italia. Salvo alcune
eccezioni, molte esperienze non sembrano riuscire ad adeguarsi e
sfruttare le potenzialità del mezzo...
Secondo me si intrecciano componenti
diverse. Innanzitutto, come qualsiasi altro settore, anche
l’informazione sconta la crisi economica di lungo periodo che c’è
in Italia. In più l’informazione subisce una ulteriore crisi
dovuta alla transizione al digitale, così non è facile reperire le
risorse necessarie per innovare. Inoltre, per un lunghissimo periodo,
le versioni online delle principali testate non erano integrate con
le edizioni cartacee; e sino a poco tempo fa non si sarebbe mai
“bruciato” uno scoop e neanche un mezzoscoop pubblicandolo online
prima che nell’edizione su carta. Anche perché il giornale di
carta si paga, mentre il giornale online si legge gratis… Per quanto riguarda un discorso più
ampio sul giornalismo digitale in Italia è vero che non ci sono
grandi innovazioni tali da poter competere con gli Stati Uniti.
Questo dipende anche da avverse condizioni generali: ad esempio
sviluppare il data journalism in Italia è praticamente
impossibile perché abbiamo una legge che rende molto difficile
l’accesso ai dati delle Pubbliche Amministrazioni, figuriamoci per
accedere a dati di istituzioni private (vedi foia.it).
Il contesto non è molto favorevole allo sviluppo e all’innovazione
del giornalismo digitale, a partire dalla Legge sulla Stampa del
1948 che ci porta a dover discutere sul serio nel 2013 se un blog sia
stampa clandestina o meno. Comunque in Europa le esperienze di
giornalismo digitale sono comparabili alle testate omologhe in Italia
come il Post, LINKIESTA, Fanpage ecc.. Con l’eccezione
dell’esperienza francese di Media Part, un sito che fa giornalismo di inchiesta di qualità, a pagamento e
con
i conti piuttosto in ordine. Ma è un esempio abbastanza unico.
FS: Una dei paragrafi che ho letto subito è stato quello su IlPost.it, curioso di sapere la tua opinione su questo prodotto editoriale verso il quale nutro giudizi contrastanti. Ne descrivi il suo "approccio didattico" (non da tutti apprezzato) e nel complesso esce un quadro del giornale molto positivo. Quali sono i suoi punti di forza?
Da un punto di vista tecnico IlPost.it
è tra i nativi digitali quello che, a mio personalissimo giudizio,
offre il prodotto migliore. Sono una redazione piccola ma molto in
gamba, guardate le biografie
di chi ci lavora: Arianna
Cavallo ad esempio ha una laurea in filologia romanza, che – avrò i miei
pregiudizi- è sempre una garanzia. Lavorano velocemente ma hanno questa idea di
curation che va oltre la “colonna di destra” o il bruto
furto di materiali altri. È anche chiaro quali siano i loro
riferimenti nell’ambito della tradizione culturale ed editoriale:
ad es. vedo un’influenza dell’Economist nel tipo di scrittura,
nelle posizioni e ancor di più nel modo di prendere posizione.
L’impronta didattica è del tutto manifesta – anzi da decenni non
si vedeva una volontà così apertamente dichiarata di ammaestrare il
lettore. Tutto ciò rende Il Post un progetto piuttosto ambizioso e
inedito, almeno per il digitale. Su molti contenuti, e soprattutto
nel modo di trattarli, si colloca in contrasto più o meno aperto con i grandi giornali e cerca un altro tipo di
pubblico. Per quanto riguarda gli orientamenti
dei collaboratori e blogger: ci scrivono persone con approcci molto
diversi, e alcuni non mi piacciono per niente. Mentre tutti amiamo
Gipi e Makkox, ovviamente …
 |
| Esempio (31/01/13) citato nell'ebook dell'approccio didattico de il Post |
DF: Nel libro scrivi: «fa
giornalismo pure il cittadino che documenti in un blog la situazione
del verde pubblico nella sua città o le condizioni delle mense
sociali». Come si distingue tra giornalismo e informazione?
Non sono molto interessato a
definizioni di essenza. Anche perché vedo che chi vuol dare
definizioni stringenti di cosa è il giornalismo spesso ricorre a
esempi che non rispecchiano per nulla quello che è il lavoro
giornalistico nella quotidianità. Se riteniamo giornalismo solo la
superinchiesta di due anni condotta sotto copertura sulla corruzione
del governo dobbiamo dire che il 99% del giornalismo professionale
italiano, quello che ci troviamo tutti i giorni sul Corriere online o
in edicola, non è giornalismo. Io credo, e non mi trovo a dover
difendere o attaccare una categoria professionale, che faccia
giornalismo anche chi crea una mappa del verde pubblico, lo ispeziona
ad intervalli regolari e documenta queste cose in un formato
accessibile ad altri. Non pretendo che la mia definizione sia quella
corretta, solo vorrei che chi definisce, nella teoria, il giornalismo
in forma alta e chiusa facesse poi i conti con un giornalismo
italiano che è, inevitabilmente e meno inevitabilmente, molto
diverso.
DF: Avere una colonna di blog è
una delle caratteristiche delle testate online. Qual è il valore
aggiunto dei blog e come vengono utilizzati dalle diverse testate?
Attualmente mi sembra che Il Fatto sia
quello che utilizza meglio il potenziale dei blog, anche se i
contenuti sono molto diseguali. Se guardi la colonna di sinistra dei
blogger del Fatto, trovi sia giornalisti come Gomez e Travaglio sia
persone che, pur svolgendo un’altra professione, sono iscritte
all’OdG, ad es. Guido Scorza e Alex Corlazzoli (suo il post
più letto del FQ nel 2012). Poi ci sono altri come Francesca
Coin, del gruppo di ROARS
o Giovanna Cosenza, docente di semiotica all’Università di
Bologna, che non sono iscritte all’Ordine dei Giornalisti e tengono dei blog interessanti. Altre testate, come Il Corriere della
Sera, si sono recentemente mosse in questa direzione ma mostrano di
faticare un po’ con questo diverso modo di comunicare. I blogger
del Corriere sono per la maggior parte giornalisti che si “dimidiano”
in blogger e scrivono degli articoli editoriali che chiamano
post. Alcuni belli, altri meno ma li trovo comunque molto
tradizionali. Poi il Corriere preferisce fare blog tematici multi
autore, e questa è un’idea interessante. Repubblica, invece,
sebbene abbia i suoi blogger (anche ottimi, ad es. il “fotocrate”
Smargiassi) non li integra quasi per nulla nella comunicazione in
homepage, quindi direi che non ci punta molto. Per quanto riguarda i “nativi
digitali” (testate che nascono online, ndr), l’Huffington Post
con la sua colonna di blogger a me sembra che stia confermando la
propria natura di ibrido poco riuscito. Anche gli altri nativi
digitali, da Fanpage a Linkiesta a Il Post, hanno spesso un parco
blogger.
DF: A proposito dell’Huffington
Post: come ricordi anche nel libro, nelle intenzioni della Direttrice
Lucia Annunziata, avrebbe dovuto coniugare “la grande tradizione
del giornalismo civico del Gruppo Espresso, e l’intuizione di
Arianna Huffington sul nuovo mondo che la rete ha formato”. La mia
sensazione è che l’Huffington Post Italia sconti un po’ di
complesso di inferiorità nei confronti dalla carta stampata.
Al contrario. L’Huffington Post
dovrebbe rappresentare proprio la testata digitale che supera le
testate tradizionali su carta. È l’unico nativo digitale che può
contare su una piattaforma tecnologica avanzatissima e su contenuti
internazionali molto numerosi e talvolta anche di ottimo livello
(quelli delle altre edizioni di Huffington Post). In Italia possono
sfruttare anche la partnership con il Gruppo L’Espresso (questo
modello “ibrido” è stato applicato anche in Francia, con il
gruppo Le Monde). Al momento non stano ancora raggiungendo numeri
altissimi, e l’ibrido non mi pare riuscito: non viene cioè
sfruttata la piattaforma tecnologica per veicolare “la grande
tradizione del giornalismo civile dell’Espresso”. Guardando al
peso editoriale, non sembra che gli articoli dell’Huffington Post
abbiano una grande rilevanza per il giornalismo digitale in Italia,
ed è una circostanza piuttosto notevole, se si guarda alle risorse
che hanno, all’enfasi con cui è stato accolto il loro arrivo in
Italia e anche alla forza dell’edizione americana. Grazie
all’infrastruttura tecnologico-editoriale sono destinati a
crescere, ma non credo che arriveranno a volumi di traffico tali da
impensierire Repubblica o il Corriere. L’alleanza del Gruppo
L’Espresso con l’Huffington Post è stata dettata dalla paura che
quest’ultimo decretasse la fine delle grandi testate. L’idea era:
“Unisciti al nemico che non puoi sconfiggere”. Ma al momento mi
pare che il Gruppo L’Espresso stia trainando molto l’Huffington
Post (pensate solo all’ampio box da mesi sulla home di
Repubblica.it).
class="twitter-tweet"> lang="it">
HuffPo: Cinghiali mutanti all'attacco della Valsesia! Hanno H e Cs-137 in più! twitter.com/jumpinshark/st…
— jumpinshark (@jumpinshark) 07 marzo 2013
DF: A mio avviso esiste un problema
di conservazione e gestione, anzi manutenzione, delle informazioni
pubblicate online. Innanzitutto c’è un grande flusso di
informazioni che rischia di essere perso. Ma anche non sembrano
esistere policies che regolino ad esempio la cancellazione di post o
notizie o procedure per la rettifica. Recentemente sul Fatto è stato
cancellato un post che parlava di una presunta proposta di legge del
M5S…
Credo che la vicenda
sia andata così: un blogger ha pubblicato un post su una
“proposta di legge alla Regione Lombardia” da parte del M5S per
eliminare l’obbligatorietà delle vaccinazioni; ma veniva linkato
come fonte solo un meet-up dove una singola persona proponeva alla
discussione comune questo tema.
DF: Al di là dal caso specifico
vedo leggerezza nel modo in cui si affrontano episodi come questi.
Non basta dire: “non va bene, lo faccio sparire dal mio sito”, è
necessario individuare delle procedure per gestire questi casi, che
pure accadono normalmente nella pratica giornalistica.
In realtà
quel post non è sparito, si trova ad esempio su Giornalettismo.
Come afferma la legge di cancellazione da internet (ricordata ancora
recentemente da Mantellini), in rete è molto difficile cancellare
qualcosa per sempre. Quel post conteneva gravi inesattezze di
contenuto e questo porta ad un’altra questione: sul mio blog posso
scrivere qualsiasi stupidata e la responsabilità è soltanto mia,
non avendo una struttura editoriale dietro. Invece è ammissibile che
una testata come Il Fatto pubblichi in un blog sul suo sito una cosa
così chiaramente mal documentata come quella riportata sopra? E come
si deve comportare, dopo aver commesso uno sbaglio così grande? In
Italia ogni testata gestisce questi processi in modo informale,
diciamo. In altri paesi ci si comporta diversamente, anche con
eccessi deliziosi… Ad esempio sul New York Times nel 2012 hanno
pubblicato un servizio molto bello sull’autismo, e un paio di
giorni dopo sotto all’articolo hanno pubblicato un erratum perché
avevano sbagliato
il nome del My Little Pony caro alla ragazza autistica. Il Guardian mette errata corrige in
fondo per qualsiasi minimo errore. Da noi invece spesso semplicemente
si cancella perché “tanto su Internet vale tutto”. Ma questo è
più un problema culturale, dell’imporsi di pratiche professionali
condivise nel gestire l’informazione su internet. Noi non ci siamo
ancora arrivati e molte volte ci sono delle “disinvolture” che a
me paiono ingiustificabili. Ma, per tornare all’episodio del
Fatto, quel post non sarebbe mai stato pubblicato su carta, perché
lì un minimo di controllo editoriale fattuale su dati così
chiaramente errati viene fatto (credo). Poniamoci il problema della
conservazione su internet, anche delle cose inesatte, ma soprattutto
bisogna porsi il problema della qualità delle informazioni
pubblicate per far sì che taluni cose facilmente controllabili non
trovino dignità di pubblicazione neanche sul web dove pure tutto è
velocissimo. Dobbiamo poi
accettare che con le nuove
forme di creazione e diffusione delle notizie sul web, le modalità
di archiviazione delle notizie tradizionali non sono più possibili.
Nell’emeroteca tradizionale si conservano le edizioni dei
quotidiani, che appunto uscivano una volta al giorno, ma attualmente
non esiste qualcosa che tracci come cambia la homepage del Corriere o
di Repubblica ogni due ore, o come cambia la singola virgola oil
singolo refuso… È tutto molto più complesso, compresso e
ravvicinato, con aumenti vertiginosi del volume dell’informazione.
In qualche modo tutto o una qualche approssimazione del “tutto” è
conservato, ma non ci si può rapportare per analogia a forme di
archiviazione delle informazioni tradizionali. Questo non vuole
essere una giustificazione della mancanza di una procedura per le
rettifiche dei pezzi online. Nel caso che usiamo come esempio
avrebbero forse potuto mettere in cima una rettifica del tipo:
“questo post contiene queste informazioni inesatte e viene
mantenuto solo ai fini documentali” e appunto conservarlo al suo
indirizzo originale. Però il problema è che qui l'errore è talmente
grande e compromette talmente il pezzo da rendere difficile un qualsiasi
recupero editoriale, anche in forma di pura documentazione. In ogni
caso l'eliminazione di un url pubblicato in un quotidiano online è per
me una misura estrema. Mantenere la pagina originale e in essa, al
limite, avvertire che era stato pubblicato un articolo poi ritirato mi
pare sempre preferibile.
DF: Guardando i dati sugli accessi
unici ai siti di informazione che pubblichi nel libro, Repubblica e
il Corriere sono al primo e secondo posto, nonostante non sfruttino a
pieno potenzialità per rendere il proprio sito “sticky”
. Come se le abitudini di lettura siano simili a quelle della carta
ed i lettori “sfogliassero” i giornali, anche online...
Prima di tutto prendiamo solo come
indicativi quei numeri assoluti - soprattutto certi parametri sono
difficili da misurare e vi sono vari altri dettagli da considerare.
Tipicamente il lettore entra sull’homepage di Repubblica, guarda le
notizie più importanti nella colonna di sinistra, ne apre due o tre,
poi si fa un giro nella colonna di destra coi boxini morbosi e
chiude. Certo lo sfogli come faresti con il giornale di carta, perché
Repubblica e il Corriere si sono imposte come possibili fonti
principali di informazione.
Questo però è il soprattutto comportamento dell’utente che "ama informarsi", poi ci sono i
lettori che cliccano da Facebook o da Twitter, chi usa gli
impaginatori come Zite etc.. Bisogna considerare la mole di notizie
che producono ogni giorno Repubblica e Corriere e l’archivio che
mettono a disposizione degli utenti. È ovvio che i numeri siano più
alti rispetto ad una start up digitale che fa 20 pezzi al giorno, o
all’Huffington Post Italia che ha un nucleo ancora ristretto di
contenuti originali.
DF: Quindi, secondo te, è un
problema quantitativo e non di autorevolezza.
È abbastanza ovvio, Il Post ha una
redazione di circa 6 persone, a Giornalettismo non credo siano molti
di più… Quanti giornalisti lavorano nella redazione di Repubblica
online? I nativi digitali si trovano a fare concorrenza a delle
strutture molto più grandi. Oltretutto in questo momento c’è
un’illusione ottica per cui il giornalismo digitale pare tutto
uguale, ci sono invece delle enormi differenze nelle risorse, sia
nelle redazioni, sia nella raccolta pubblicitaria. Non possiamo
comparare in termini di qualità o di quantità realtà tanto
distanti senza prima specificare il peso delle differenze per quelle
valutazioni. In questo momento i guadagni digitali
si fanno soprattutto con le pubblicità sulle pagine. La teoria è
“più pezzi hai, anzi più pagine, più inserzione e possibilità
di attirare un lettore hai”. Questo non è un modello sostenibile,
o, per essere sostenuto, richiede la produzione di pezzi sempre più
veloci e di conseguenza meno accurati? OK.
La strada che è stata percorsa- fino alla nausea - è quella degli
introiti pubblicitari per migliaia pagine viste (CPM, CPI)
che ha portato ai noti eccessi già discussi. E anche l’ammirato e
innovativo Guardian alla fine è costretto a puntare sui numeri e
quindi finisce col mettere la curiosità sul panda, anche se fa la
sua colonna di destra con misura e grazia. La questione è, in un certo senso,
molto semplice: fare informazione costa, il modello CPM non funziona
se non in casi particolari, il paywall a molti sembra una soluzione
infallibile, ma ancora poche persone in Italia sono disposte a pagare
per l’informazione sull’online. Soprattutto in questa fase,
quanti sono quelli che pagherebbero (potrebbero pagare) 20 € al
mese di abbonamento per ogni giornale da loro apprezzato? Esistono
però anche altre possibili fonti di entrata: il Guardian ha persino
un sito, Soulmates, per trovare l’anima gemella, vende biglietti
per gli spettacoli, fa corsi; e sui corsi ed eventi punta ad es. pure
Il Sole 24 Ore.
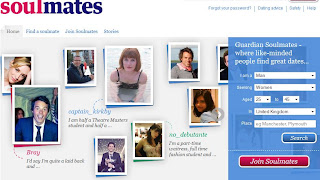 |
| "Guardian Soul Mates- Online dating site anda dating agency" |
DF: Nel contesto competitivo che
disegni, secondo te c’è bisogno (o spazio) per tanti giornali
generalisti? Non credi che siti di informazione specializzata in
grado di attrarre pubblici specifici possano avere maggior successo?
Parli dei cosiddetti siti verticali
come LaVoce.info, che appunto
si regge anche su finanziamenti dei lettori. Ancora una volta
da noi queste esperienze sono meno sviluppate e le condizioni non
facili. Nazione Indiana, Le Parole e le Cose, Alfabeta 2, Carmilla
sono ottimi blog culturali su base volontaria, gestiti da docenti che
pubblicano saggi e da scrittori che pubblicano testi narrativi e
critici. Il ritmo di pubblicazione è di pochi pezzi al giorno.
Alcuni, come Alfabeta 2, hanno una rivista cartacea a fianco.
Potremmo quindi dire: per superare la dimensione volontaria facciamo
una cosa talmente bella e innovativa da spingere il pubblico a pagare
il lavoro (perché, ehm, di lavoro si tratta) degli autori. Ma
considera la crisi economica - circostanza che non è da
sottovalutare in nessuna analisi contemporanea dei consumi culturali
- la non abitudine a pagare per i contenuti online e appunto la
disponibilità gratuita di moltissimi contributi di buono e persino
ottimo livello. La somma di tutti questi fattori rende non facile
l’avvio a pagamento in Italia di una testata digitale
specializzata, almeno in campo letterario, artistico, culturale.
DF: Ma secondo me si sconta anche
la questione della minor autorevolezza del mezzo online. In fondo noi eravamo disponibili ad andare una volta alla
settimana in edicola a comprare Orwell. Un’operazione come Pubblico
ha fatto la fine che ha fatto,
ma così il un bacino di competenze e autorevolezza che stava
costruendo Orwell viene disperso solo perché non ci sono i soldi per
uscire su carta…
La
carta stampata ha indubbiamente un’autorevolezza maggiore
dell’online! Pensa che "Pubblico", un giornale letto davvero da
pochissime persone, pubblicò un pezzo su una probabile ricandidatura
di Napolitano e il giorno dopo il Presidente inviò una nota di
smentita al giornale. Blogger come Leonardo che hanno (credo) un
numero di visitatori unici al giorno superiore a quello dei lettori
di "Pubblico" e non ricevono certo lettere del Presidente della
Repubblica. In Italia la carta ha ancora molta più autorevolezza del
digitale. Punto. Certo possiamo auspicare una modifica di questi
rapporti e anzi è molto probabile che la situazione cambierà
abbastanza velocemente, alcuni stanno lavorando attivamente in tal
senso, ma ad oggi la situazione è questa.
 |
| Uno degli articoli di Jumpinshark per "Orwell" (20/10/12) |
FS: Tra cartaceo e digitale c'è una bella differenza anche per quel che riguarda il mercato di narrativa e saggistica. Pensi ci sia possibilità che il tuo ebook venga pubblicato su carta? Lo vedrei bene come manuale per aspiranti scienziati della comunicazione! :D
Quali sono i vantaggi di un ebook? Per
un lettore almeno questi: un ebook non occupa (quasi) spazio e in un
ereader ci stanno moltissimi libri, così non sei costretto a
caricare uno zaino con 20 kg quando via in viaggio. Per l’editore
almeno questi, sempre riferendoci allo spazio: non ci sono problemi
di magazzino o di resi. E come costano i mq occupati dalle librerie
in caa, così costano i magazzini. Se domani si scoprisse che il mio ebook
ha venduto 10.000 copie, forse Minimum Fax proporrebbe l’edizione
cartacea. Ma non so quanto senso possa avere quest’operazione tra
qualche mese: il pubblico a cui l’ebook era in primo luogo rivolto
probabilmente lo ha acquistato (o lo sta acquistando in queste
settimane) e sarebbe davvero difficile diffonderlo ulteriormente. E
poi su carta il prezzo certo non potrebbe certo essere di 2€,
quindi non credo vi sia una possibilità reale. Al più, se l’ebook
avesse davvero un grande riscontro si potrebbe pensare a un’edizione
molto ampliata, anche su carta, ma insomma sarebbe semplicemente la
base per qualcosa di diverso.

"Facebook sai che sei gay prima di te" è solo un esempio tra i tanti di titoli ridicoli di articoli ridicoli. Ben venga chi "denuncia" queste robacce. Domanda: non ho il kindle ne altri dispositivi, si può scaricare il pdf del libro?
RispondiEliminaGiacomo
Anche io sono (ero) abituato/affezionato al pdf, ma ti consiglio di scaricarti il saggio in formato epub e aprirlo su un browser con apposite estensioni. Io usavo "epubreader" per Firefox (ecco una lista di alternative https://addons.mozilla.org/it/firefox/search/?q=epub&cat=1%2C0&appver=10.0.2&platform=windows trovi servizi simili anche per chrome). Poi ci sono programmi gratuiti per la gestione degli ebook come Calibre e Adobe Digital edition che permettono di leggersi il contenuto dei libri senza problemi.
Elimina